[Please scroll down for the english version]
Un veterano rimpatriato cerca il suo amore perduto mentre traduce lettere romantiche di donne giapponesi ai soldati americani.
Quasi una “presa diretta” dello stato d’animo e delle condizioni del dopoguerra, Love Letter mette in scena la vita di Reikichi (uno straordinario Masayuki Mori), ex veterano della marina: un uomo triste e smarrito che vive con il fratello in un povero appartamento sui tetti, simile a quello di Settimo cielo (Borzage,1927) ma svuotato d’ogni speranza. Reikichi è alienato da un presente cinico ed un passato sentimentale che lo tormenta: l’uomo, infatti, non ha mai dimenticato il suo amore di gioventù, Michiko (Yoshiko Kuga), di cui non possiede che una vecchia lettera d’amore. Reikichi si trascina per strade, locali e stazioni ferroviarie nella speranza di scorgere il volto di Michiko; la sua sofferenza silenziosa e lo sguardo velato di malinconia ne fanno l’emblematico antieroe maschile del dopoguerra, deluso, affranto e privo di certezze.
Per non vivere più alle spalle del fratello, Reikichi accetta di lavorare come traduttore in un’agenzia che offre alle ragazze giapponesi la possibilità di scrivere “lettere d’amore” ai soldati americani (ormai rimpatriati) con cui hanno avuto una relazione durante l’Occupazione. L’uomo disprezza l’amoralità di quelle che considera traditrici vendute al nemico, ma un giorno entra in agenzia proprio Michiko, anche lei ex amante di un militare americano; ed è qui che la Storia si scontra con la tragedia individuale. L’improvvisa gioia d’aver ritrovato la donna amata e sognata per anni muta rapidamente in rifiuto; Reikichi non può accettare il pensiero di una Michiko prostituita al nemico, fosse anche per disperazione o necessità di sopravvivenza.
Notevole la scelta della regista di deviare dalla schematicità di una banale romance tratteggiando il quadro lucido, realista dei rapporti che vennero a crearsi tra le donne giapponesi e i militari americani durante l’Occupazione: un argomento affrontato in modo esplicito, brutale, ma non privo di comprensione. La vita è fragile, sembra suggerirci la sua visione; troppo fragile per non perdonare le cadute e la debolezza umana.
La scena che vede Reikichi ritrovare Michiko, in una stazione affollata, è di una bellezza struggente, comparabile forse solo all’incontro tra Lisa e Stefan in Lettera da una sconosciuta (1948) di Ophuls: un frammento di felicità pura e fuggevole, che trova espressione in un’immagine poetica – i loro corpi finalmente riuniti e incorniciati dalla porta di un treno, che ripartendo li “dimentica” e li fa svanire agli occhi dello spettatore. È per finezze come queste che la regista si distingue, illuminando il reale di emozioni potenti: le sue immagini ritagliano brevi e struggenti haiku, pause poetiche in cui un movimento emotivo trova pienezza e conclusione.
Tanaka è molto attenta all’uso espressivo del primo piano. Michiko è inquadrata da vicino, il suo viso è trattato come un paesaggio: lacrime, segni, pieghe di tristezza toccano lo spettatore profondamente. Anche per Reikichi spesso la macchina da presa ricorre a inquadrature ravvicinate, differenti dai “mezzi primi piani” di Ozu: il dolore umano, secondo la regista, va osservato senza compromessi, per ritrovare la pietà, la comprensione in un presente incerto e disseccato. L’apparizione delle “ragazze di strada”, dirette, vivaci, brutali, sembra anticipare le amiche di Cabiria nel celebre film felliniano; e la stessa Tanaka si ritaglia un cameo da donna perduta, mostrandoci come in poche battute sia possibile definire un personaggio in modo indelebile. Il film si chiude sospeso in un’afasia temporale e psicologica: Reikichi piegato su se stesso, Michiko quasi votata all’autodistruzione; ma ancora viva, bianca, palpitante.



English Version
A repatriated veteran searches for his lost love while translating romantic letters from Japanese women to American soldiers.
Almost a “direct take” on the postwar mood and condition, Love Letter brings to the screen the life of Reikichi (an extraordinary Masayuki Mori), a former navy veteran: a sad, disoriented man who lives with his brother in a poor rooftop apartment, reminiscent of Seventh Heaven (Borzage, 1927) but stripped of all hope. Reikichi is alienated both from a cynical present and from a sentimental past that haunts him: he has never forgotten his youthful love, Michiko (Yoshiko Kuga), of whom he possesses only an old love letter. He drags himself through streets, bars and railway stations hoping to glimpse Michiko’s face; his silent suffering and the melancholy in his eyes make him the emblematic postwar anti-hero — disappointed, crushed, and bereft of certainties.
To avoid living off his brother any longer, Reikichi agrees to work as a translator in an agency that offers Japanese girls the chance to write “love letters” to the American soldiers (now repatriated) with whom they had relationships during the Occupation. He despises the amorality of those he considers traitors sold to the enemy, but one day Michiko herself walks into the agency, she too a former lover of an American soldier; and here History collides with individual tragedy. The sudden joy of finding the woman he has loved and longed for over the years quickly turns into rejection; Reikichi cannot accept the idea of a Michiko prostituted to the enemy, even out of desperation or the need to survive.
Remarkable is the director’s choice to stray from the schematic simplicity of a banal romance, portraying instead a clear-eyed, realist picture of the relationships that formed between Japanese women and American soldiers during the Occupation: an issue handled explicitly, even brutally, yet not without understanding. Life is fragile, her vision seems to suggest; too fragile not to forgive human weakness and human falls.
The scene in which Reikichi finds Michiko in a crowded station is heartbreakingly beautiful, perhaps comparable only to the encounter between Lisa and Stefan in Ophuls’ Letter from an Unknown Woman (1948): a fragment of pure, fleeting happiness expressed through a poetic image — their bodies finally reunited and framed by the doorway of a train which, as it departs, “forgets” them and lets them fade from the viewer’s sight. It is for such subtleties that the director shines, illuminating reality with powerful emotions: her images carve out brief, piercing haiku, poetic pauses in which an emotional movement finds fullness and completion.
Tanaka pays great attention to the expressive use of the close-up. Michiko is filmed from near, her face treated like a landscape: tears, marks, folds of sadness touch the viewer deeply. Reikichi too is often captured in close shots, different from Ozu’s “medium close-ups”: human pain, the director seems to say, must be observed without compromise in order to rediscover pity, understanding, amid an uncertain and drained present. The appearance of the “street girls,” direct, lively, brutal, seems to anticipate Cabiria’s friends in Fellini’s famous film; and Tanaka herself gives a cameo as a fallen woman, showing how in just a few lines a character can be defined indelibly.
The film ends suspended in a kind of temporal and psychological aphasia: Reikichi bent over himself, and Michiko almost turned toward self-destruction; yet still alive, white, trembling.


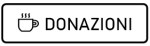



















Lascia un commento