Jin, un mediocre impiegato, passa le notti a correre per strada con lo skateboard. Un giorno incontra lo skater radicale Ikeda e inizia a vivere in modo ancor più estremo la sua passione, andando incontro a problemi con i cittadini, risse, fughe, fino allo scontro finale con due vendicatori.
Jin è uno di quei salariati di cui è costellato il cinema giapponese a partire dal muto (Tokyo chorus, Yasujirō Ozu, 1931, o Koshiben ganbare, Mikio Naruse, 1931, per citarne alcuni). La figura del sararīman, completo scuro e camicia bianca, vessato da un capo dispotico e sottoposto ad ogni sorta di abuso (mobbing, sfruttamento, umiliazione) nel 1989 portò anche un regista anarchico e incendiario come Shin’ya Tsukamoto a inventare Tetsuo, uomo-macchina sottoprodotto dell’alienazione urbana (vera visione d’inferno in stop motion per le strade di Tokyo). Ma non dimentichiamo anche le parole di Chishū Ryū in Early Spring (Sōshun, 1956, Yasujirō Ozu): “Questo è il destino degli impiegati… A volte odio il mio lavoro. Tutti oggi sono insoddisfatti”
Il sararīman di Wings of the Abyss (2021, Yuki Kobayashi) è la versione contemporanea dell’impiegato schiacciato dal sistema: il regista ci mostra sin dall’incipit la vita avvilente di Jin, costretto a grottesche riunioni di lavoro e a un abuso quotidiano che lo rende opaco persino a se stesso. Kobayashi non fornisce alcun indizio riguardo alla psicologia di Jin, proprio perché egli agisce ma non pensa, mosso da un grumo di istintività e da una condizione di costante alienazione. Alla miseria delle ore d’ufficio risponde con un unico, totalizzante impulso: attraversare la città sullo skateboard, saltando su gradini e panchine, tra marciapiedi affollati e carreggiate.
Nel momento in cui Jin sale sullo skateboard, la regia si svincola da coordinate convenzionali e reinventa lo spazio in forme liberatorie, all’insegna della velocità, dell’impermanenza, di luci e colori ammirati nella loro valenza astratta. Lo skateboard diviene strumento politico in antitesi a una società rigidamente performante.
Kobayashi si serve di un editing particolarmente personale, denso di tagli e jump-cuts anti-narrativi, volto a riprodurre l’intensità dell’hic et nunc: a Jin interessa solamente il “sentimento presente” della corsa sullo skate; tutto ciò che precede e segue lo skateboarding non è, ai suoi occhi, che una sequenza di raccordi.


L’incontro con lo skater Ikeda e il suo gruppo di sbandati intensifica il desiderio di libertà e sradica Jin ulteriormente dai codici sociali. La banda vive per soddisfare la propria pulsione – lo skateboarding sempre più estremo – e considera gli spazi urbani come un enorme skate-park da dominare (e danneggiare) senza alcuno scrupolo etico. Uno degli aspetti più interessanti del film è lo sguardo entomologico di Kobayashi, che trattiene ogni forma di giudizio e asciuga l’immagine da sottotesti morali: al regista preme riprodurre la pura ebbrezza della corsa – servendosi di sinuosi movimenti di macchina, accelerazioni, composizioni astratte e dinamiche – così come viene vissuta da Jin e dal resto del gruppo.
Questa vena “documentaria” (che molto ha in comune con il Gus Van Sant di Elephant, 2003) viene spezzata dall’arrivo, nell’ultima parte del film, dei “vendicatori in abiti bianchi”, due personaggi che imprimono una nuova direzione alla vicenda. La coppia – che si muove in sincrono e attacca con leggerezza coreografica – porta alle estreme conseguenze il clima di violenza e controllo emersi finora in segnali sporadici. Gelidi e determinati come in un thriller alla Haneke, i “giustizieri” si accaniscono brutalmente contro gli skaters per punirli del loro sprezzo delle regole. Kobayashi gestisce con rigore l’esplosione della furia e del sangue, incanalando gli scontri in sequenze rapide, di grande suggestione grafica e dal forte carico sensoriale.
Autoprodotto dal regista, Wings of the Abyss è chiaramente un lavoro d’amore, che denuncia – a partire da una prospettiva inedita – tanto la violenza “antropologica” connaturata alla società giapponese, quanto l’illusione dell’anarchia. Ma è anche un’opera densa di cinema (da Lynch a Bergman, soprattutto nella sequenza del “passaggio macabro” all’aldilà), che ripercorre il passato per dare nuova forma all’immaginario presente. Particolarmente suggestiva la citazione di Texas Chainsaw Massacre (1974), con un Jin-Leatherface che brandisce uno skate quale arma di libertà.




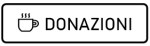

















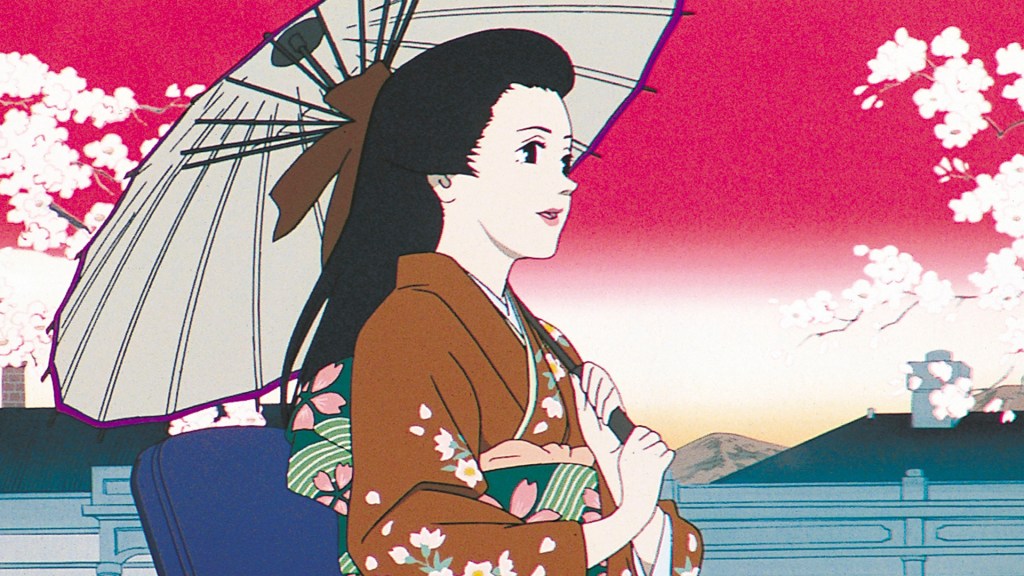


Lascia un commento